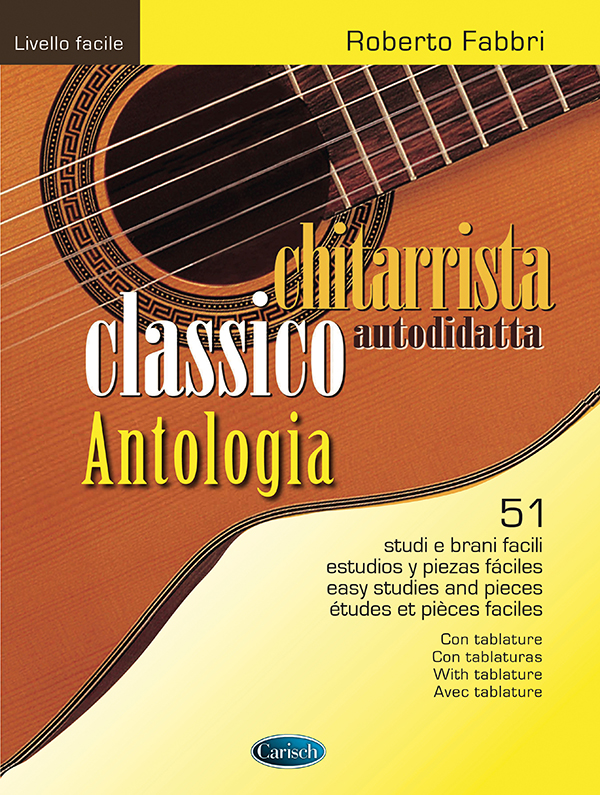Molti lo avranno visto aprire i concerti e suonare la lap steel nel fortunato Ecco Tour che Niccolò Fabi sta portando in giro per l’Italia. Roberto Angelini è a sua volta un cantautore di talento, nonché un ottimo chitarrista acustico e un musicista a tutto tondo. Come cantautore è nato nell’ultima ondata della stagione d’oro del Locale di Roma, che ha visto nascere la cosiddetta ‘seconda scuola romana’, animata all’inizio oltre che da Fabi da artisti come Daniele Silvestri, Max Gazzè e Alex Britti. Come chitarrista ha vissuto in famiglia la geniale influenza del patrigno Vittorio Camardese, straordinario chitarrista non professionista che, tra gli anni ’60 e ’70, animava le serate del Folkstudio di Roma con i suoi standard jazz arrangiati sulla corde di nylon con una fantasiosa tecnica a due mani ante litteram. Inoltre è diventato un grande appassionato e conoscitore della musica e della chitarra di Nick Drake, al quale ha dedicato nel 2005 l’album di riproposte Pong Moon – sognando Nick Drake. Nel 2008 ha eseguito le parti di chitarra in un concerto tributo a Drake a Fiesole, con la voce di Marco Parente e Robert Kirby, storico arrangiatore degli archi per il cantautore inglese, a dirigere l’Orchestra di Fiesole. E nel 2010 Joe Boyd, produttore di Drake, lo ha chiamato a partecipare al tributo ufficiale A Way to Blue nel suo passaggio in Italia. Tra le varie collaborazioni di Angelini ricordiamo poi Elisa, il Collettivo Angelo Mai, gli Afterhours, Emma, Pier Cortese e, tra le produzioni, Massimo Giangrande e Francesco Forni. Nell’ottobre scorso è uscito infine Phineas Gage per la Fiori Rari, quarto suo album di inediti: per essere di un cantautore si presenta come un disco piuttosto anomalo, quasi per metà in veste solo strumentale, che mette in evidenza una base di chitarra acustica che dialoga efficacemente e con molto gusto con l’elettronica. Dal vivo l’album è proposto dal solo Angelini sul palco a suonare diversi strumenti, con l’ausilio in regia e alla gestione delle macchine sonore di Daniele ‘Coffee’ Rossi, ex Tiromancino e Velvet. Per parlare di questo e non solo, siamo andati a trovare Roberto nel suo Clivo Studio alle pendici delle Mura Vaticane.
Ascoldando Phineas Gage si sente già dal brano di apertura una chitarra acustica suonata in tapping, e subito sorge spontanea la domanda: qual è stata la tua formazione musicale e, in particolare, l’influenza esercitata dal tuo patrigno Vittorio Camardese, che ho avuto la fortuna di ascoltare tante volte al Folkstudio di Roma?
La vicinanza di Vittorio è stata importantissima per la mia formazione, mi ha trasmesso la passione per la chitarra e per la ricerca musicale. La sua in realtà era una tecnica incredibile, perché non era fine a se stessa, si sviluppava dalla necessità di andare oltre l’esecuzione di uno standard. E quindi non era una tecnica che si poteva apprendere: bisognava prima imparare la totalità della musica per poi andare oltre, come ha fatto lui. Io cercherò, nella mia esistenza artistica, di arrivare a poter rifare le sue cose, anche se ogni cosa ha senso in un periodo storico preciso. Lui è cresciuto nel dopoguerra, quando il jazz era una musica vissuta di contrabbando e i primi dischi arrivavano sottobanco dagli americani: mi raccontava che li portava il figlio di Mussolini, Romano. La chitarra l’aveva presa da un barbiere, una chitarra con le corde di metallo, che gli faceva venire il sangue alle dita. Era il periodo del jazz meraviglioso, dello swing. Io non sono cresciuto in quel periodo, sono cresciuto in un altro momento storico. Lo swing che aveva lui, lo ricercherò tutta la vita e probabilmente non ne sarò mai soddisfatto.
Mi dicevi anche che lui aveva una certa difficoltà a trasmetterti i dettagli dei suoi fraseggi, perché era un modo di suonare tutto suo, ‘istintivo’…
Eh, sì, lui andava quasi in trance quando gli ‘entrava’ bene la cosa. Gli si ‘incastrava’ il labbro e il fraseggio che tirava fuori – avendo io poi studiato negli anni e ascoltato un po’ di musica – potrei definirlo come una bellissima fusione fra Django Reinhardt e Wes Montgomery: usava le ottave di Wes, il pollice, un po’ di roba gitana; chiaramente quelli erano i suoi chitarristi preferiti. Ogni volta che faceva una frase bella, io lo interrompevo e volevo studiarla, magari com’ero abituato a fare con le tablature dell’epoca; ma lui non la sapeva rifare e mi bloccava. In realtà lui non voleva che rifacessi le sue cose, voleva che imparassi dei concetti più alti della musica, dei concetti che si basavano sull’armonia, sulle voci di un accordo che viaggiano, sull’ascolto attento dei bassi. Io, da buon ‘pischello’, ero affascinato dalle ‘sfuriate’ tecniche, volevo farle pure io. E lui invece mi bloccava, diceva: «No, questa la imparerai, ma non è questa la cosa importante; la cosa importante è capire l’accordo, sentire i bassi quando cambiano, imparare il sapore delle note, la ricerca della ritmica, l’essere quadrati»… E quindi sono cresciuto con le sue bellissime e importantissime lezioni di vita e di musica. Dopodiché, intelligentemente, lui mi ha lasciato la libertà di seguire il mio percorso musicale, che come quello di tanti altri ragazzi è nato dalle cantine, dall’unione con gli altri compagni, dal dividersi gli strumenti e dal suonare insieme cose che alla mia epoca erano il rock, dal punk di “Anarchy in the U.K.” ai Metallica. Insomma, dai quattordici ai diciassette anni ho suonato un po’ di rock con gli amici, ma ogni tanto portavo qualche accordo speciale, ‘brasiliano’, che mi svelava Vittorio; e mi dicevano: «Ma che è ’sta roba?»
Nella tua famiglia, anche tuo nonno ha avuto un ruolo importante sul piano musicale.
Sì, ho avuto la fortuna di crescere da bambino in una famiglia particolare, in cui mio nonno – il papà di mia madre, che di base faceva il pranoterapeuta – metteva a frutto il grande successo che aveva in questa attività per organizzare dei weekend in una casa vicino a Roma, a Palombara, dove venivano musicisti da tutte le parti. Si comportava come un mecenate, i musicisti avevano da mangiare, avevano da suonare, c’era la piscina, ci si divertiva, c’erano stanze dove passare la notte e tutti suonavano come dei pazzi dalla mattina alla sera. Io ho dei vaghi ricordi, tra l’altro, di cartoni animati visti con Chet Baker! Da lì, inizialmente il mio approccio alla musica non è stato chitarristico, è stato legato piuttosto alla registrazione. Avevo una piccola tastiera, con la quale scoprii la tecnica di registrazione del ‘ping pong’: con due registratori a nastro, mettendo ‘Rec’ da una parte e ‘Play’ dall’altra potevo registrare su più tracce. E i miei, vista questa mia predisposizione, decisero di comprarmi un multitraccia Tascam a quattro piste: quello fu l’inizio della mia passione per la composizione, che poi mi portò anni dopo – da chitarrista – a scrivere canzoni, ad aver voglia comunque di mettermi in discussione come autore. Ma a casa mia, in realtà, non volevano che facessi il musicista: perché la musica non portava da nessuna parte, non dava sicurezza. Volevano che io studiassi forte, che facessi un percorso universitario. Vittorio, pur suonando, era un medico radiologo e, dal suo punto di vista da jazzista, considerava tutte le difficoltà di una vita nel jazz e anche i vari ‘demoni’, dall’alcool alle droghe, oltre alla costante dipendenza da un datore di lavoro, dai proprietari di locali, dai capi orchestra. La mia piccola intuizione all’epoca fu quella di dire a Vittorio: «Io non voglio fare il jazzista, non ci tengo, non sarei neanche in grado e non è la mia vita; però potrei scrivere musica, magari questa potrebbe essere la mia strada, diversa dalla tua». Quindi non volevo nemmeno mettermi in competizione con lui, competizione che avrei perso dieci a zero! Avere in casa un chitarrista così bravo era uno stimolo, ma poteva anche allontanare dal desiderio di fare musica. Quindi lì è iniziato il mio percorso di cantautore-chitarrista.
Il tuo apprendimento della musica sulle tablature era più legato alla chitarra elettrica suonata con gli amici. Come è avvenuto poi il passaggio alla chitarra acustica?
A un certo punto ascoltai Tuck & Patti, con questo fantastico chitarrista Tuck Andress, capace di fare degli accompagnamenti totali, globali, in cui c’era dentro il basso, l’armonia, la linea melodica…
Mi viene da dire che Tuck Andress è la perfetta fusione tra Vittorio e la canzone…
Sì, bravissimo, perché c’era lo swing e c’era anche l’applicazione di quella tecnica alla canzone. Mi piaceva tantissimo la sua copertura totale dell’arrangiamento, con la ritmica, il basso, il canto in mezzo, il canto sopra. Quindi, prendendo spunto da lì, pensai: «Forse, lavorando un po’ con quello che mi ha insegnato Vittorio, un po’ con quello che posso imparare ascoltando Andress e riportando il tutto sull’acustica»… E da lì ho cominciato a scrivere le mie prime canzoni in italiano, a suonare nei piccoli locali con gli amici che ti vengono a sentire, fino ad arrivare a ventidue-ventitre anni a suonare a Il Locale di vicolo del Fico a Roma, che per la mia generazione, con tutte le dovute differenze, era il corrispettivo del Music Inn e del Folkstudio di una volta. Dopotutto gli artisti che sono venuti fuori da lì sono definiti come la ‘seconda scuola romana’.
Artisti come Max Gazzè, Alex Britti e te, pur essendo degli ottimi strumentisti, avete scelto spontaneamente questa via della canzone, anche senza le remore intellettuali e ideologiche che potevano avere quelli della generazione precedente, entrando nel circuito della canzone pop in senso lato, com’è il caso dei primi tuoi dischi…
Credo che ognuno l’abbia fatto in maniera personale e a modo suo. Forse uno dei primi a Roma a iniziare un percorso interessante è stato Daniele Silvestri. Nel ’96-’97, lui fu uno dei primi a dimostrare che era più importante cosa scrivevi piuttosto che come lo cantavi. Noi venivamo da un periodo in Italia in cui si era affermato il ‘bel canto’, la canzone italiana era fatta dal cantante che ti copriva due ottave, con il ritornello che doveva aprire a voce piena come nei grandi pezzi del Festival di Sanremo. Si era persa un po’ quella vena cantautorale degli anni settanta. Invece, in qualche modo, Silvestri con grande intelligenza, Fabi con ironia, Britti forse il più pop di tutti, Gazzè con inclinazioni alla Battiato nella sua scrittura, ognuno ha osato utilizzare la propria voce non convenzionale per raccontare delle cose. Oggi come oggi non avrebbero la possibilità di esprimere la loro arte, a X Factor verrebbero cacciati tutti al primo turno, perché siamo tornati a una vocalità in cui si devono ‘aizzare’ le folle attraverso la pura forma… cosa che chiaramente finisce nelle mani del burattinaio di turno! Ma qui entreremmo in un discorso molto ampio. Fatto sta che in quel periodo sono stato influenzato tantissimo da Daniele Silvestri, che mi ha trasmesso l’idea che – pur non essendomi mai sentito un cantante e non sentendomi tale neanche oggi – potevo comunque usare la mia voce per raccontare le mie storie. E da lì sono partito, ero della seconda generazione rispetto a loro e mi son vissuto la parte finale del Locale, però quella situazione mi è servita per arrivare a un contratto discografico con la Virgin.
Puoi raccontarci dei tuoi primi dischi, Il sig. Domani del 2001 e Angelini del 2003, culminati l’anno seguente nell’EP Ripropongo, dove riproponevi appunto alcune canzoni di Angelini in versione acustica?
Questo primo contratto l’avevo ottenuto cantando a occhi chiusi, sempre seduto su uno sgabello, con la chitarra acustica arpeggiata che era l’ossatura di tutta la canzone. La Virgin mi aveva messo sotto contratto per quel tipo di scrittura e sono andato avanti così per due anni. Poi è sopraggiunta una crisi, ci sono state difficoltà, dovute all’avvento di un mondo nuovo basato principalmente sull’imprenditoria, sull’azienda, su nuove priorità, sui conti che devono assolutamente tornare. Da lì è nato il secondo disco Angelini, che invece è assolutamente lontano dall’acustico, è molto pop e molto allineato alle mode dei tempi in cui è uscito. Ma subito dopo è arrivato l’EP Ripropongo, che è stato una mia necessità di ritornare rapidamente al mio mondo, nonostante l’anno passato a far capriole nel mainstream italiano tra Festivalbar e altre amenità… È stato un anno molto divertente e molto istruttivo, che mi ha fatto capire molto bene che cosa non volevo fare nella vita!
E nel 2005 arriva Pong Moon – Sognando Nick Drake, l’album dedicato al repertorio di Drake insieme al violinista Rodrigo D’Erasmo.
Il mio primo album fu anticipato nel 1999 da un EP realizzato con chitarra acustica e quartetto d’archi. Mentre lo facevo e avevo la sensazione che stavo scoprendo qualcosa di meraviglioso, e forse di unico, Pino Marino, altro cantautore romano che ha attraversato la vita dell’ultimo Folkstudio e del Locale, mi fece capire che qualche anno prima c’era stato un certo Nick Drake… E da lì ho conosciuto Drake! A quel punto, siccome Ripropongo non era bastato per curarmi l’anima, per curarmi ancora meglio scelsi di dedicarmi completamente a un progetto che facesse bene a me. Pong Moon non l’ho fatto per nessun altro se non per me. Il disco era semplicemente un motivo per poter suonare i brani di Drake, non aveva nessuna intenzione di aggiungere nulla alla sua meravigliosa opera. Io andavo in giro a presentarlo e consigliavo alla gente di comprare, se non ce li aveva, i dischi suoi, non il mio. Il disco era un motivo per andare in giro a suonare quel repertorio e, in questo modo, abbiamo incontrato un sacco di appassionati dell’epoca di Drake, così come un sacco di ragazzi giovani. Da lì poi ci fu un bel tributo a Villa Pamphili a Roma, organizzato con molti artisti italiani che sono venuti a partecipare. E anche la bellissima esperienza di poter collaborare con Robert Kirby, l’arrangiatore storico degli archi nei dischi di Nick Drake, qualche anno dopo a Fiesole per un altro tributo con tutta l’orchestra. La conoscenza con Robert mi ha permesso di capire due o tre cose in più su Drake, attraverso racconti in prima persona. Come immaginavo anch’io, Nick non era assolutamente triste, soprattutto ai tempi del primo album. Anche se le canzoni erano malinconiche, ma la malinconia non è per forza un motivo di tristezza… La tristezza gli venne poi, a causa degli insuccessi. La sua era una depressione di quando da una parte ti senti molto forte, ma non ti senti compreso.
Come Tenco…
Esatto, e onestamente, nel mio piccolissimo, questo è il motivo per cui ho abbracciato idealmente Drake. Perché, nel mio minuscolo, intorno a me e al mio primo disco si erano formate un sacco di attese , di clamori. E quando l’attesa relativa a un disco non viene soddisfatta, è molto difficile, soprattutto quando sei alla prima prova, soprattutto a ventiquattro-venticinque anni. Ti arriva una mattonata sulla testa e non è facile riprendersi. Io devo proprio a Drake, e al percorso che ho fatto con lui, la mia ripresa, la mia piccola ripresa personale.
Come hai imparato le parti di chitarra di Nick Drake?
Di base attraverso tanti ascolti. Poi c’è stato un personaggio che si chiama Chris Healey, il quale ha messo insieme in un sito [www.nickdraketabs.com] un sacco di tablature diverse, di idee diverse da parte di persone che amano Drake in tutto il mondo, cercando di capire quali erano le migliori. Quindi ci sono state discussioni, forum sempre aperti su accordature, trovate, posizioni del capotasto. Ed io ho utilizzato tantissimo il suo portale per imparare e scoprire accordature, ritmiche: è stato un bellissimo viaggio, un bello studio che chiaramente mi porto ancora addosso.
In questo tipo di repertorio caratterizzato dalle accordature alternative, dalla ricerca sulle accordature, hai incontrato anche altri artisti come Michael Hedges, David Crosby?
Io ho sempre ascoltato tutto, però poi, da quando sono ragazzino, ho sempre pensato che ci siano due strade: quella di chi studia tutte le cose che ascolta e diventa un meraviglioso esecutore di cose belle altrui; oppure quella di chi ascolta comunque tutto, ma cercando in qualche modo una propria vena creativa, la propria strada. Forse devi essere un po’ pazzo, ma io ho scelto la seconda. E un lavoro sistematico di studio l’ho fatto solo con Nick Drake. Io sono il peggior chitarrista da spiaggia che ci possa essere, non conosco una canzone di nessuno. Quel lavoro l’ho fatto solo con Nick e l’ho fatto a ventisei anni, dopo anni di esperienza personale nella scrittura di canzoni. In effetti ho pensato di avere delle piccole caratteristiche in comune con lui, in particolare il fatto che tutte le sue melodie giravano intorno alle sue parti di chitarra, alle ‘trovate’ della chitarra. Per me è sempre stato così da quando sono bambino, cioè è la chitarra che governa il brano, è la chitarra che mi dice – attraverso un percorso quasi folle – di che cosa devo parlare in quel pezzo. Non arrivo mai con un testo scritto e poi lo musico, non esiste per me questa cosa. Io giro intorno a degli accordi, a una ritmica, e piano piano è la chitarra che tira fuori il tema: il giro di chitarra già lo sa qual è la melodia giusta e quali sono le parole più armoniche, che stanno bene, che non sembrano appiccicate.
Usi sempre questo metodo di scrittura delle canzoni o possono esserci approcci diversi?
Questo è il mio metodo, poi è chiaro che mantenere tutta la vita un metodo può essere anche noioso. Quindi a volte mi capita di fare esattamente il contrario, per curiosità: per esempio mi è capitato di prendere una poesia e di musicarla. Ma di base parto da giri di chitarra. A volte mi sono capitati dei giri che mi sono portato appresso per anni, senza trovare le parole giuste; oppure dei giri dai quali dopo due secondi uscivano subito le parole. E comunque il primo passo nasce sempre da un rapporto d’amore con lo strumento. Per le parole, a volte parte magari una frase in finto italiano… Non bisogna mai cantare in finto inglese, perché se cominci in inglese, quel tuo inizio suonerà sempre meglio di qualunque cosa tu possa scrivere in italiano. Se vuoi scrivere in italiano, è meglio partire da un suono che è già italiano…
Un’altra tappa che mi è parsa importante, e che in qualche modo anticipa la dimensione di Phineas Gage, è il progetto SoloLive del 2009, nel quale eseguivi le tue canzoni da solo suonando vari strumenti, dalla chitarra acustica alla chitarra lap steel modello Weissenborn, dal piano al Theremin e al didgeridoo, mescolando il tutto con l’elettronica, i loop e i suoni campionati.
Sì, è vero, lì sta l’inizio di un percorso che sto vivendo ancora adesso. È un percorso nato un po’ dalla generale difficoltà di poter fare musica attualmente con il gruppo, a causa dei cachet che diventerebbero troppo alti. Inoltre, oggi, la maggior parte degli amici con cui sono cresciuto e ho suonato fanno i musicisti: per me è un orgoglio enorme, perché ci conosciamo tutti da vent’anni, stavamo al liceo insieme, quindi puoi immaginare la bellezza di ritrovarci ora a suonare con Niccolò Fabi. Però, a un certo punto, siccome sono tutti bravi, tutti sono stati ingaggiati da cantanti bravi, che possono permettersi di dare loro quello che meritano. E allora io che potevo fare? Andare a suonare chitarra e voce? Ho suonato chitarra e voce per una vita, ma adesso ci puoi solo aprire i concerti di altri artisti, facendo al massimo tre pezzi. Per portare in giro un concerto chitarra e voce, dovresti essere come minimo un Paul McCartney, che ti fa soltanto dei capolavori, dei pezzi che tutti conoscono. Altrimenti non puoi reggere, al quarto pezzo perdi l’attenzione della gente. E allora ho cominciato a dilettarmi con questa storia del SoloLive, che in realtà mi ha dato tantissime soddisfazioni e che non riesco più ad abbandonare. D’altra parte, avendo a disposizione il mio Clivo Studio, che è la mia grande gioia, non faccio altro dalla mattina alla sera: io ho avuto fortuna, mi è stato concesso il lusso di fare il musicista e questa è una cosa di cui devo comunque rendere conto al dio della musica! Perciò studio continuamente strumenti, mi piace, adesso sto provando con la pedal steel, con l’ukulele, con il banjo…
Arriviamo così a Phineas Gage: nell’insieme dell’album, che è quasi per metà strumentale, si nota un perfetto equilibrio tra la base della chitarra acustica ‘conduttrice’ e un contorno di elettronica realizzato con grande gusto. Qual è la tua idea dell’uso dell’elettronica?
Poiché avevo messo cinque anni, dal 2004 al 2009, per fare il disco precedente La vista concessa, in quest’ultimo caso io e Daniele ‘Coffee’ Rossi – che mi ha aiutato nella registrazione e nella produzione dell’album – abbiamo deciso di darci un mese di tempo per finire tutto. Siamo venuti in studio e abbiamo passato due giorni a preparare tutti gli strumenti, in maniera tale che fossero facilmente abbordabili e utilizzabili, per evitare di perdere tempo tra un’idea e la sua realizzazione, per avere subito la possibilità di registrare e soprattutto di improvvisare tutto. La decisione di usare l’elettronica e dei loop deriva, come hai capito bene, da SoloLive. In un certo senso, però, SoloLive ero stato costretto a farlo in quel modo. Adesso invece mi sono detto: «Sai che c’è, facciamo proprio un disco che poi posso suonarmelo da solo, con i loop già in scrittura». Così in questo mese siamo stati in studio dalla mattina alla sera, con tre canzoni scritte prima e per il resto… che le cose andassero come dovevano andare!
Infatti l’impressione è proprio questa, di immediatezza…
È un disco in cui c’è tantissima improvvisazione. Ci sono tanti amici che sono passati: «Cos’hai appresso?» «Il violoncello!» «E dai, ci suoni qualcosa?» Così, senza pensarci troppo. Mi piaceva proprio l’idea di un contrasto tra il disco che aveva richiesto tanto tempo – in cui avevi pensato in modo cerebrale a ogni nota, rifacendo i pezzi finché non ne potevi più, al punto che quando li dovevi suonare dal vivo li odiavi – e questo disco realizzato quasi all’impronta.
Ed è un disco molto unitario, quasi non c’è altro da aggiungere a quello che abbiamo detto. Mi resta però la curiosità di capire com’è realizzato per esempio quel bel suono arpeggiato in “Vento e pioggia”.
È una pedal steel…
Ah, pensavo che entrasse solo nella seconda parte…
No, è tutta una parte di pedal steel dall’inizio, anche la parte arpeggiata. È suonata non proprio da pedal steel, ma come una chitarra normale, ed è la prima cosa che ho suonato con questo strumento, premendo tutti i pedali possibili: quando li premi tutti, uno dopo l’altro, esce fuori quell’armonia là, con qualche stonatura che diventa come un effetto di chorus!
A questo punto sembra quasi superfluo chiederti come porterai Phineas Gage dal vivo…
Come anche in SoloLive, siamo sempre io e ‘Coffee’. Io sono sul palco e lui è il mio alter ego in regia: gestisce i suoni e filtra, gioca e suona con me attraverso delle apparecchiature che permettono di effettare, modificare gli spazi sonori, i riverberi, i delay, il noise; inoltre si occupa anche delle proiezioni di video di animazione e di illustrazione che accompagnano lo spettacolo, realizzati per i miei pezzi nel corso degli anni. Insomma, in due montiamo su un bel ‘pandemonio’ e infatti, grazie a dio, i concerti vanno benissimo. Portiamo in giro per due lire uno spettacolo che dovrebbe costare un sacco di soldi. Questo è oggi il nostro quotidiano di musicisti. Poi può anche capitare, come ci sta succedendo adesso, di andare a suonare in tour con Niccolò Fabi… e allora troviamo i grandi teatri, i tecnici che ti cambiano le corde e ti preparano gli strumenti, il grande rispetto per le persone e il lusso di poter suonare in una situazione in cui non devi pensare ad altro che a suonare. Ma normalmente noi, quando andiamo in giro a suonare, facciamo i camionisti, montiamo e smontiamo l’attrezzatura, installiamo il tutto sul palco e ci mettiamo più di un’ora, facciamo il soundcheck, suoniamo, rismontiamo tutto…
Con Niccolò Fabi avete fatto anche alcuni concerti in trio acustico, con te e Pier Cortese…
…Fabi, Stills & Nash! Eh, sì, è stato divertente e credo che lo riproporremo anche altre volte! Con Pier inoltre condivido anche il recente album Discoverland, che portiamo in giro insieme e che è basato sulla nuova rilettura di brani importanti di musicisti e cantautori italiani e internazionali.
Suonare in trio acustico comunque è già una dimensione più proponibile in concerti importanti, rispetto al suonare da solo voce e chitarra.
Assolutamente. Puoi giocare anche con tre voci. Io poi, in situazioni del genere, in questi anni mi sono un po’ specializzato sulla lap steel, anche se la chitarra acustica rimane lo strumento che amo, su cui ho passato più tempo e che imbraccio con più facilità. Però ho capito che con la chitarra acustica, suonando con gli altri, in realtà non vai da nessuna parte; perché di solito l’acustica la suona sempre il cantante. Quindi è stata una fortuna se qualche anno fa mi sono avvicinato alla lap steel e, di conseguenza, ho ampliato le mie conoscenze su questo mondo della chitarra slide. Per Fabi sono essenzialmente un suonatore di lap steel acustica. È una lap steel suonata – lo spero e ci provo – con personalità, nel senso che non è per forza in stile blues, ma la utilizzo con una serie di escamotage, anche perché inizialmente non sapevo suonarla e dovevo comunque trovare delle soluzioni personali. In trio ci sono due acustiche e la lap steel, e si crea così un piano sonoro interessante anche con le tre voci. La formula ha retto bene, ci siamo divertiti ed è piaciuta tanto.
Arriviamo per finire a parlare più in dettaglio della tua strumentazione.
La cosa di cui sono felicissimo sono le due Cole Clark acustiche che uso attualmente. Sai, quando registri in studio, conta la chitarra acustica come tale, con due bei microfoni davanti. Quindi se hai una bella Martin, magari del ’74 come quella che ho avuto anni fa, sei a posto. Ma quando sei dal vivo, il chitarrista acustico è forse il musicista con più problemi in assoluto rispetto agli altri: la chitarra elettrica l’attacchi e vai, la batteria la suoni, il basso pure, le tastiere sono quelle. Invece la chitarra acustica è un dramma. E circa quattro anni fa ho scoperto queste Cole Clark, di un costruttore che lavorava alla Maton e se ne è staccato. Lui ai tempi era uno dei primi a montare due sensori a contatto all’interno della cassa, i Face Brace Sensor Acoustic Pickup Systems. Così ho contattato il distributore italiano Suona.it e – forse una delle poche volte nella vita – sono riuscito a vendermi abbastanza bene: lui è stato carinissimo e mi ha dato due chitarre. Sono le due chitarre che uso sempre, perché dal vivo hanno molto più ‘legno’ rispetto a un normale piezo. Le attacco a una bellissima cassa Aer, che d’altra parte uso come monitor personale e come D.I. perché – andando spesso in giro a suonare rock’n’roll – non di rado capitano dei monitor osceni. Questo se suono acustico. Se invece suono nella dimensione del SoloLive, con tutto l’armamentario, allora tutto passa attraverso un mixer Mackie a 16 canali, il Mackie passa dentro il nuovo looper RC-300 della Boss a 3 canali, da lì rientra nel mixer e il mixer va nell’impianto. Quindi tutto quello che suono può produrre dei loop. La lap steel poi è una Gold Tone modello Weissenborn costruita in Cina, che suona benissimo con un sistema Dean Markley Trilogy con pickup magnetico, trasduttore e microfono a condensatore. Come steel guitar invece ho una Gretsch made in China, che mi suona meglio di una Gibson originale degli anni ’50! E pensa, ho scoperto che anche Kaki King, con cui ho avuto il piacere di partecipare a uno spettacolo di Vera Di Lecce, a parte le chitarre Ovation che usa, ha le stesse lap steel Gold Tone e steel guitar Gretsch che ho io! Infine, facendo un salto nell’elettrico, ho un unico strumento che è di grande valore, una Gretsch ‘Chet Atkins’ degli anni ’60. Quella è una cosa fantastica, con una leva dolcissima: tu praticamente l’attacchi e – anche se non sei capace – fai due note con un dito ed esce una cosa stupenda.
Andrea Carpi